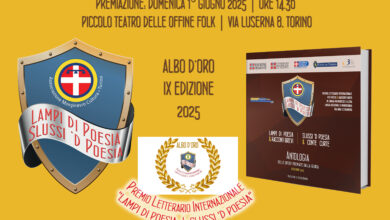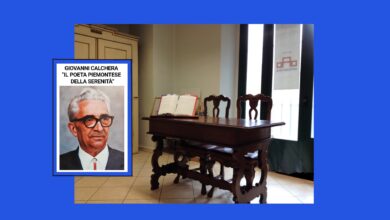Bollengo, la chiesa romanica dei santi Pietro e Paolo lungo la Via Francigena canavesana
La chiesa romanica dei santi Pietro e Paolo in Pessano sorge nel comune di Bollengo, eretta nell’ultimo quarto dell’XI secolo sulle ondulazioni moreniche che increspano il territorio canavesano alle pendici della Serra d’Ivrea.

Ci troviamo nell’area dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea, grandiosa formazione morenica modellata dall’azione del ghiacciaio balteo nel corso di una decina di glaciazioni succedutesi nel Pleistocene, lungo la diramazione canavesana di quel fascio di vie medievali indicato come Via Francigena, percorsa per secoli da viandanti e pellegrini 1
Osservando la facciata della chiesa, balza all’occhio una peculiarità architettonica: l’ingresso all’aula interna avviene tramite il campanile in facciata, secondo una tipologia conosciuta come “clocher porche“, ossia “campanile-atrio” o “campanile-androne”. Si tratta di un modello architettonico diffuso in particolare in Normandia e nel nord della Francia che trova, però, alcune significative applicazioni in area canavesana, forse portate in loco da maestranze itineranti che si muovevano lungo le diramazioni della Via Francigena mettendosi al servizio delle comunità locali.
Secondo quanto riportato dagli studiosi, il “clocher-porche”, soluzione architettonica di origine carolingia, deriva da una semplificazione delle monumentali “églises-porche” di area francese o “westwerke” delle regioni germaniche, strutture di notevole complessità, caratterizzate da un notevole sviluppo del lato occidentale dell’edificio sacro.
Tornando al caso canavesano di Bollengo, dobbiamo immaginare che la chiesa, posta in cima a un verdeggiante poggio in posizione dominante sul paesaggio, non fosse, in origine, isolata, come appare oggi, bensì circondata da un gruppo di case che costituivano il villaggio di Pessano.

Il borgo di Pessano scomparve dopo il 1250, a causa del trasferimento degli abitanti nel nuovo nucleo difensivo di Bollengo – un castello franco con annesso ricetto – che era stato costruito per iniziativa del comune di Ivrea, intenzionato a porre un freno all’espansionismo del comune di Vercelli attraverso una serie di nuove fondazioni e opere di rafforzamento di insediamenti già esistenti. Gli abitanti di Pessano raccolsero l’invito delle autorità eporediesi, che, come forma di incentivo, stabilirono l’equiparazione della loro posizione giuridica a quella dei cittadini di Ivrea, e anche le famiglie del villaggio di Paerno, situato poco più in alto, fecero lo stesso. Invece, i residenti nell’antico capoluogo di Bollengo non aderirono all’invito e rifiutarono di trasferirsi.
Il trasloco nella nuova sede abitativa ridisegnò la mappa dell’insediamento umano in questo angolo del Canavese, facendo sì che, nel volgere di qualche anno, i nuclei di Pessano e Paerno venissero abbandonati dai loro abitanti originari. Nel caso di Paerno, l’unica testimonianza architettonica superstite, che ricorda l’esistenza del villaggio, è il grande campanile romanico della chiesa di San Martino, soprannominato “Ciucarun”, che oggi si staglia isolato in una radura fra i boschi che rivestono le pendici della Serra.
Anche il borgo di Pessano, abbandonato dagli abitanti, vide sopravvivere la chiesa dei santi Pietro e Paolo che, però, rispetto al San Martino di Paerno, di cui rimase in piedi soltanto il campanile, ha avuto miglior fortuna, venendo posta sotto la tutela del Capitolo della Cattedrale di Ivrea e continuando ad essere utilizzata come punto di riferimento e di sosta a beneficio dei pellegrini che percorrevano la Via Francigena. Sul lato destro della chiesa, si nota una costruzione addossata, che alcuni interpretano come l’abitazione dell’eremita, con funzioni di custode del luogo, mentre altri ritengono sia la canonica eretta successivamente alla fondazione.

L’interno della chiesa appare, oggi, disadorno, ma affascinante nella sua semplicità. Il ciclo pittorico, che in origine doveva rivestire gran parte delle pareti laterali, sopravvive soltanto in alcuni lacerti di affresco visibili nell’area absidale, attribuiti dalla critica alla mano del “Maestro del chirurgo Domenico della Marca d’Ancona”, artista itinerante attivo in Piemonte nei primi decenni del Quattrocento e qui a Bollengo tra il 1425 e il 1432.
All’interno di un riquadro, bordato da una cornice con motivi geometrici, secondo un gusto per l’esuberanza decorativa che è un tratto distintivo dello stile pittorico proprio del Maestro del chirurgo Domenico della Marca d’Ancona, si riconoscono Sant’Antonio Abate e (forse) San Giovanni Battista, mentre dai frammenti ancora visibili sul lato sinistro dell’abside si può identificare la figura di San Giorgio che trafigge il drago, di cui è leggibile un frammento della coda (secondo un’altra versione, si tratterebbe invece di San Michele Arcangelo, che indossa un’armatura metallica, secondo il suo attributo di principe delle milizie celesti e protettore della Cristianità).
La chiesa è dotata di apertura automatizzata grazie alla App “Chiese a porte aperte“, modalità tecnologica innovativa, ideata e sostenuta dalla Consulta per i beni culturali ecclesiastici del Piemonte e Valle d’Aosta e dalla Fondazione CRT, realizzata con il contributo della Regione Piemonte, e inoltre fa parte della rete Chiese Romaniche AMI (Anfiteatro Morenico d’Ivrea).
- La diramazione canavesana della Via Francigena attraversava l’area eporediese partendo da Vercelli o da Quadrata (Verolengo) per dirigersi verso i valichi alpini valdostani. ↩︎