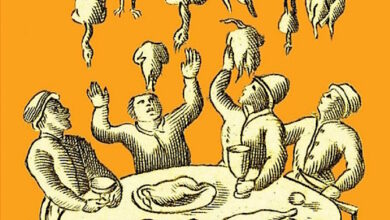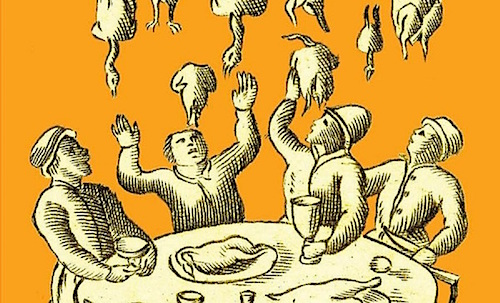
Cibo e bevande dei nostri antenati nelle canzoni piemontesi di Ignazio Isler (terza parte)
Canzone XXVI (Lamenti di due serve contro le padrone; 1748): vv. 50-63
Il pubblico di lettori (o ascoltatori) delle poesie di padre Isler doveva essere, almeno in parte, costituito da persone appartenenti alla piccola borghesia, tali da potersi permettere in casa almeno una servetta per i lavori più pesanti ed umili. Tale riflessione nasce dal fatto che una canzone, la XXVI, è costruita, con ritmo dialogico, proprio sui lamenti di due serve nei confronti delle loro padrone, costruendo così un quadretto che ha senso se pensiamo che le battute pronunciate dalle due possano trovare riscontro in situazioni vissute da qualcuno tra il pubblico.
Le due ragazze, che si chiamano l’una Slufrin-a e l’altra Margòt, nelle strofe dalla 3a alla 6a parlano, lamentandosi appunto delle loro padrone, di come vengono trattate per quanto riguarda il mangiare, mentre nelle 8a e 9a del bere. Slufrin-a si lamenta che la sua padrona (una scarman-a, cioè «spilorcia») le fa mangiare tross e euv coviss (torsoli e uova stantie, cioè quelle che si lasciano per un certo tempo nel nido per invogliare le galline a deporne altre); l’altra allora si sente subito in dovere di far rimarcare come lei debba nutrirsi di pan mufì e con la crosta dura, e poi ancora vedendoselo misurare, tale che ij can lo veulo gnanch. Torna alla carica Slufrin-a, che ricorda come la sua padrona voglia che lei cucini la mnestra e la pitansa, certo, ma a condizione che risparmi su tutto, anzi che non metta neppure sale e condimento (j’avansa la sal e ’l condiment); chiude a sua volta il discorso sul cibo Margòt, che sottolinea come la sua raramente le dia, per cucinare (për fé quàich potagiat, «per fare qualche pietanza»), burro, lardo o strutto (bur, lard o grassa), poiché, così almeno dice, l’óitum a vasta e che ’l breu sol a basta per tùit ij meinagiat («l’untume rovina e il brodo da solo basta per tutte le faccende domestiche»).
Quanto al bere, nella strofa 8a Margòt si lagna che la padrona (definita sta tigna, avara) le faccia sempre e solamente bere (tavòta mach bèive) vin ’d lambrosca,/ ch’a l’é né asil né posca,/ gnanch bon a lavé ij pé: vino di lambrusca (uva selvatica), che non è né aceto né vinello (ma si tratta di un modo di dire per significare «non essere né una cosa né un’altra»), che non va bene neppure per un pediluvio. A sua volta, Slufrin-a sostiene che la sua, di padrona, non le fa certo bere ’d vin grech o ’d malvasia, ma al lapat (cioè «agli sgoccioli, a piccoli sorsi», bevendo quel che avanza dai bicchieri; lapé significa infatti «succhiare, bere a poco a poco, come fanno i cani»), dandole per di più solamente lò dël concat, cioè il vino che, sgocciolando, si raccoglie dalle botti nel concat (nella forma moderna conchèt, cioè un piccolo recipiente di legno).
Canzone XLI (Dialogo d’un Medico con Marion; 1758): vv. 22-28, 36-42, 50-56, 64-70 e 78-84
Una situazione comune nella canzone popolare, ripresa dall’Isler nella sua canzone XLI, è quella del dialogo alternato tra il medico e la donna malata (pensiamo, per es., alla famosissima, e presente un po’ in tutta la regione, Marìa, o in alcune versioni Magna, Gioana). Causa dei disturbi della donna (nell’Isler di nome Marion) è ovviamente l’esagerazione nel mangiare e nel bere.
Vediamo dunque il pantagruelico menù della malata. J’heu mangià una supëtta,/ ma l’é na bagatela/ fàita ant una scudela/ larga com un crivel,/ e na dosen-a ’d grùe,/ e vint miche cornùe/ ansem a un quart ’d vitel(str. 4a); come inizio non c’è male: ha mangiato una zuppetta (proprio una bagattella) preparata in una scodella grande come un setaccio per il grano, ed una dozzina di gru, e venti pagnotte a forma di corno insieme ad un quarto di vitello. Dopo il commento ironico del medico nella strofa successiva, la donna continua il suo elenco. Peui tranta singh sautisse/ con set salam ’d testa,/ ch’a l’é na còsa onesta/ për fé na colassion,/ con ses galin-e nan-e/ e des baravantan-e,/ un ròst e doi giambon. Trentacinque salsicce con sette salami di testa (cioè fatto con i ritagli), che è qualcosa di giusto e normale per fare colazione, con sei galline nane e dieci padovane (ma baravantan letteralmente vale «strambo, stravagante»), un arrosto e due prosciutti. Nuovo commento del medico, che giudica queste ultime portate degne di far scomodare un medico per una visita, dopodiché la donna riprende. Lasseme dì, Sgnor Médich,/ a-i é ancor d’àutra ròba;/ j’heu mangià un dindo an dòba;/ un’òca e un bel gingòt/ con un mes rub d’anguila,/ e tut lo-lì, për dila,/ ’m ha gnanch tocà ’l gariòt. Lasciatemi dire, Signor Medico, c’è dell’altro ancora: ho mangiato un tacchino (dindo, francesismo da dinde, in alternativa alla forma schiettamente piemontese pito) in gelatina (dòba dal francese daube); un’oca ed un bel cosciotto di castrato (cfr. il francese gigue, gamba, e gigot, cosciotto) con un mezzo rubbo (misura di peso, corrispondente a poco meno di 10 chili) di anguilla, e tutto ciò, per dirla tutta, non mi ha neppure toccato il gargarozzo. Ironia del medico: una colazione tale potrebbe bastare ad un battaglione, ed allora la nostra apprendista Pantagruel aggiunge. A-i é ancor quaicosëtta,/ ch’a l’é na forma antera/ d’una bon-a gruera,/ tre tome e doi strachin;/ e peui così për rije/ j’avrai bevù tre sije/ e sinch-ses pinte ’d vin. C’è ancora qualcosina, cioè una forma intera di gruviera, tre tome e due stracchini; e poi, giusto per ridere, avrò bevuto tre secchi e cinque o sei pinte (misura di volume per liquidi equivalente a quasi 1½) di vino. Il medico osserva che la donna sembra na cardlin-a, dopodiché. A-i é peui ancor la fruta,/ ma venta gnanch contela:/ j’heu mangià na corbela/ pien-a de pom verdass./ Vint lire ’d lasaròle/ e quìndes ’d sòrbe mòle,/ disdeut mass ’d ramolass. C’è poi ancora la frutta, ma non è il caso di considerarla: ho mangiato una cesta piena di mele verdognole; venti libbre (poco meno di 7 chili) di lazzeruole (tipo di mela di sapore acidulo) e quindici di sorbe molli, diciotto mazzi di ramolaccio (specie di rafano, o ravanello). Conclude il medico indicando la cura idonea: un lavativ (cioè un clistere) fatto di un sach ëd brochëtte, trantesses lire ’d mana e mes rub d’epicoquana; quindi un sacco do chiodini, trentasei libbre di manna (lassativo usato a quei tempi) e mezzo rubbo di ipecacuana (una radice emetica originaria dell’America meridionale).
Dario Pasero
Le puntate precedenti:
PRIMA PARTE
SECONDA PARTE